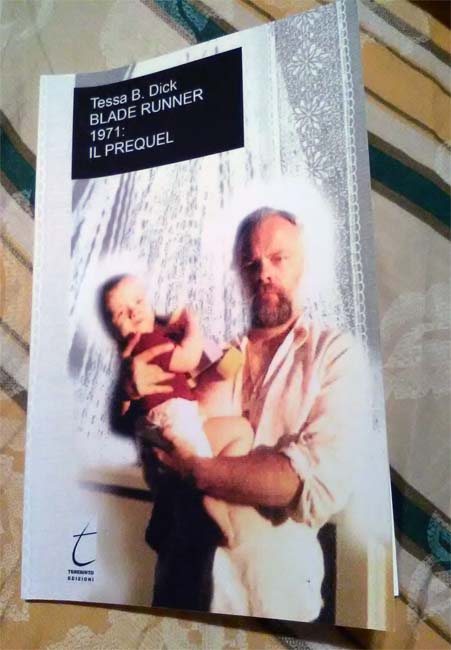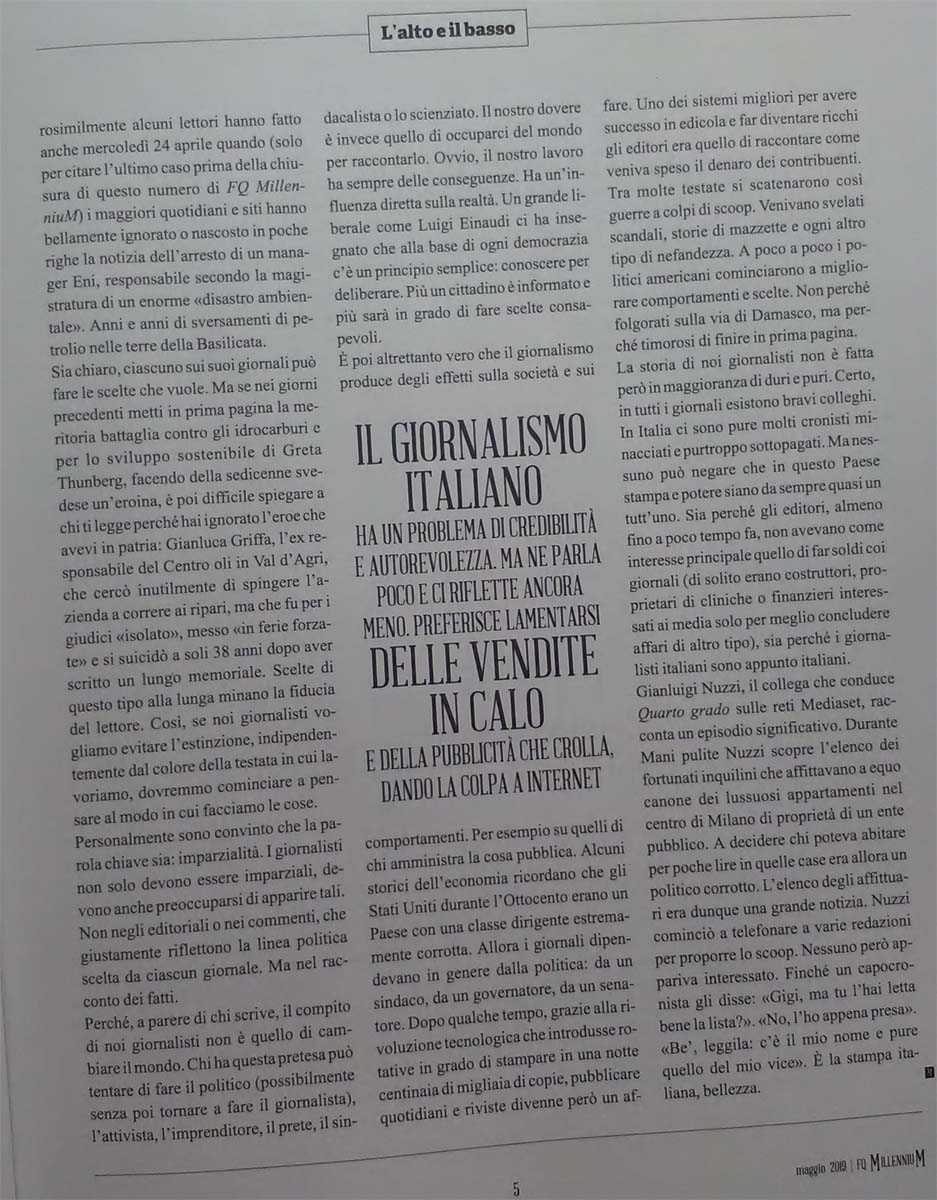Terra degli uomini di Antoine de Saint-Exupéry è come un aereo un po’ acciaccato. Rulla a strappi, ci mette un po’ troppo a posizionarsi in linea di decollo. Non ha la coinvolgente dolcezza fiabesca de Il piccolo principe né le sue pennellate di poesia. Sei come un passeggero che legge un poco annoiato in attesa della partenza. Certo i pensieri non mancano. Come chiedersi come sarebbe il mondo se non ci fossero stati i pionieri, quelli disposti a giocarsi la vita per un qualcosa che all’epoca poteva persino passare per un sogno folle. Non racconta dei suoi voli di guerra, qui, Saint-Exupéry, altrimenti con quelli non avresti dubbi, ben meglio sarebbe stato un mondo senza aerei da guerra, ma dei suoi voli commerciali. Così pensi a quei trabiccoli ciechi dentro, senza o quasi strumentazione di bordo, e ciechi fuori, senza o quasi comunicazioni con la terra. Leggi di come si orientava con le luci della costa o con quelle delle città, in un buio talmente fitto che persino le stelle potevano confonderlo apparendo luci umane. Le Ande erano un pericolo costante per velivoli che non potevano ancora volare a certe altezze. E poi c’erano i pionieri dei pionieri, quelli che partivano per segnare le rotte sconosciute che poi avrebbero percorso tutti ma a cui loro, ancora una volta in più, accedevano alla cieca. Poi, senza accorgertene, il libro ha girato il muso sulla pista, si mette a correre come un forsennato e raggiunge la quota massima in metà del tempo che impiegherebbe un aeroplano vero. Ha sbuffato fino a pagina 67 (edizioni San Paolo), ci saranno altri vuoti d’aria, altri pensieri profondi ma non tanto bene espressi, ma il cielo se l’è conquistato.
«Ma un altro miracolo dell’aereo è quello di tuffarsi dritto al cuore del mistero. Come un biologo, da dietro l’oblò, studiate il formicaio umano.»
L’autore fa uno scalo «nei pressi di Concordia, in Argentina», viene ospitato da una famiglia, affascinante nella sua bizzarria. La descrizione della casa e delle persone che la abitano creano pagine di grande bellezza.
«Qui ogni cosa era un po’ malandata, e in modo adorabile, come un vecchio albero coperto di muschio…»
«La vedete, voi, una squadra di muratori, di falegnami, di ebanisti, di stuccatori piantare in mezzo a un passato del genere il loro armamentario sacrilego e rifare in otto giorni una casa che vi sembrerà di non aver mai conosciuto e dove avrete l’impressione di essere un ospite? Una casa senza misteri, senza angoli nascosti, senza trabocchetti sotto i piedi, senza segreti – una specie di atrio del municipio?»
«(…) più chiavi di quante non fossero le serrature della casa, e nessuna delle quali ovviamente funzionava per nessuna serratura. Chiavi meravigliosamente inutili, che confondono la ragione, che fanno sognare sotterranei, cofanetti sepolti, monete d’oro.»
Le ragazze, intelligentemente stravaganti, erano «Giudici che sapevano distinguere le bestie furbe da quelle ingenue, in grado di capire dal passo della loro volpe se l’animale fosse o meno d’umore trattabile, e in possesso di una conoscenza altrettanto profonda dei moti interiori.»
La pagina migliore è quella che chiude il capitolo, perché credo che siano pochi gli uomini in grado di concepire un pensiero così bello: «Oggi sogno. Tutto è lontanissimo. Cosa sono diventate quelle due fate? Di certo si sono sposate. Ma sono cambiate? (…) Che cosa fanno in una casa nuova? Che cosa sono diventate le frequentazioni di erbe selvatiche e serpenti? C’era in esse qualcosa di universale. Ma viene il giorno in cui nella ragazza si risveglia la donna. Si sogna di assegnare alla fine un “dieci”. C’è un “dieci” che pesa in fondo al cuore. A quel punto si presenta un imbecille. Per la prima volta quegli occhi così acuti si ingannano e lo illuminano di colori seducenti. Se quell’imbecille declama dei versi, si crede che sia un poeta. Si crede che capisca di pavimenti rotti, si crede che ami le manguste. Si crede che quella confidenza lo lusinghi, quella di una vipera che si dondola sotto la tavola tra le sue gambe. Gli si dà il cuore, che è un giardino selvatico, a lui che ama solo parchi ben curati. E l’imbecille porta via la principessa riducendola in schiavitù.»
Raccontando di un abitante del Sahara: «Si ricorda di quel gusto di mare aperto che l’uomo, una volta che lo ha assaporato, non dimentica più.» Non posso che concordare, il mare, una volta che ti ha preso, non ti lascia più.
Una ventina di pagine più in là ancora mare, ma questa volta raccontando di sé. È tragica questa frase, come se contenesse una premonizione: «Ma sono in aeroplano. Grosso o no non posso atterrarci. E questo mi procura, ne ignoro il motivo, un assurdo senso di sicurezza. Il mare fa parte di un mondo che non è il mio. Il problema qui non mi riguarda, neppure mi minaccia: non sono attrezzato per il mare.» Antoine de Saint-Exupéry sparì in volo durante la seconda guerra mondiale e il suo aeroplano verrà ritrovato solo nel 2004 in mare, nel Sud della Francia.
Ho scritto in questo blog da qualche parte che a noi viaggiatori poco viaggianti sembra di iniziare a vivere solo quando le ruote dell’aereo si staccano da terra. Ovviamente a lui il concetto viene meglio: «Ho bisogno di vivere. Nella città non c’è più vita umana. Non si tratta affatto, qui, dell’aviazione. L’aereo non è un fine, è un mezzo. Non è per l’aereo che si rischia la vita. Non è neanche per l’aratro che il contadino fatica. Ma, grazie all’aereo, si lasciano le città e i loro contabili e si recupera una vita contadina.»
La passione dell’uomo, che può portare a grandi cose o alle peggiori nefandezze. In entrambi i casi, è cieca e sorda.
«Per questo forse il mondo di oggi inizia a scricchiolare attorno a noi. Ognuno si esalta per religioni che gli offrono questa pienezza. (…) Allora, non stupiamoci. Chi non aveva nessuna idea di quello sconosciuto che stava addormentato dentro di lui, ma che l’ha sentito svegliarsi in un covo di anarchici a Barcellona (…) non conoscerà altro che una verità: la verità degli anarchici. (…) Se aveste obbiettato a Mermoz, quando si inoltrava in direzione del versante cileno delle Ande, con la sua vittoria nel cuore, che si sbagliava, che forse la lettera di un mercante non vale il rischio della sua vita, Mermoz avrebbe riso di voi. La verità era l’uomo che nasceva in lui quando trasvolava le Ande.»
Beata l’epoca in cui leggendo un vecchio libro non troveremo niente che ci ricordi il presente.
«Ma le carrozze di terza classe ospitavano centinaia di operai polacchi, licenziati dalla Francia, che tornavano in Polonia. (…) E mi sembravano aver perso per metà la natura umana, sballottati da un capo all’altro dell’Europa dalle correnti economiche, strappati dalla loro casetta del Nord (…) non avevano messo insieme altro che gli utensili da cucina, le coperte e le tendine, in pacchi mal legati e gonfi fino a scoppiare. Ma a tutto quello che avevano accarezzato o sedotto, a tutto quello che erano riusciti ad addomesticare in quattro o cinque anni di soggiorno in Francia, il gatto, il cane e il geranio, avevano dovuto rinunciare (…) E pensai: il problema non è assolutamente in questa miseria, in questa sporcizia, in questa bruttezza. Ma questo uomo e questa donna un giorno si sono conosciuti e di certo l’uomo ha sorriso alla donna (…) E lui, che oggi non è altro che una macchina per zappare o martellare (…) Il mistero è come siano diventati questi fagotti di creta. (…) Un animale invecchiato conserva la sua grazia. Perché questa bella argilla umana si è sciupata? (…) e mi dissi: ecco il volto di un musicista, ecco Mozart bambino, ecco una bella promessa della vita. I piccoli principi* delle leggende non sono in nessun modo diversi da lui (…) Qui c’è piuttosto una specie di ferita, di offesa al genere umano. (…) Quello che mi tormenta non può essere sanato dalle mense per i poveri. A tormentarmi non sono né quelle cavità, né quelle gobbe, né quella bruttezza. Mi tormenta che c’è un po’, in ciascuno di quegli uomini, di Mozart assassinato.»
* Terra degli uomini è stato pubblicato quattro anni prima de Il piccolo principe.
…al terra-terra degli uomini
Al lavoro un giornalista mi allunga un libro di Selvaggia Lucarelli, scrive davvero bene, dice. Per quel poco che la conosco concordo. Falso in bilancia è già un bel titolo. Il libro scorre veloce, anche per via dell’impaginazione, per arrivare a pagina 50 ci metti lo stesso tempo che impiegheresti ad arrivare alla pagina 9 del Dottor Živago. Purtroppo anche lei si adegua alla moderna scrittura, piena di paragoni per descrivere una cosa reale o un’emozione. Per un po’ va bene, anche perché serve a fare esercizi di ironia, a metà del libro mi ha già stufata. È più facile descrivere una situazione comparandola a qualcosa che già esiste e che si è quasi certi che strapperà un sorriso che non trovare parole nuove. In breve, è il report della sua eterna battaglia con la bilancia, perché Selvaggia ama ingozzarsi di qualunque cosa, per poi pentirsi, dimagrire e ricominciare a mangiare di nuovo arrendendosi al cibo che comunque la rende felice. Non ha sbagliato la Lucarelli a scrivere un libro così, soprattutto perché lo riferisce ai tempi dei social network in cui basta un niente (5/6 chili di troppo, una ruga) per essere distrutti moralmente, anche se sei una persona famosa e bella come Vanessa Incontrada. Me la ricordo questa brutta faccenda, l’avevano presa di mira mentre era incinta, ma non gli scemi del villaggio virtuale bensì i giornali, che poi sono spesso l’innesco dei massacri da tastiera. Mi chiedevo quanto si può essere meschini e ignoranti a prendersela con una donna che aspetta un figlio. A volte mi guardo intorno, sui mezzi di trasporto, e vedo dei gran cessi di uomini con le dita nel naso che compulsivamente armeggiano con lo smartphone. Sono cessi fuori e dentro e mi chiedo quanti di loro facciano parte dei massacratori. Ah, va da sé che c’è il corrispettivo femminile. Io lo identifico con quelle che hanno una voce odiosa e ciononostante ti costringono a sopportarla, che hanno gli occhi strabuzzati da pazza, che sono perennemente permeate da un’aggressività difensiva pure quando nessuno se le fila. Quindi il libro della Lucarelli ha un suo senso e bene ha fatto a scriverlo, quello che non ha senso è che questi libri esistano, perché siamo noi a determinare che ci possa essere mercato per un certo tipo di libro. Siamo passati dal guardare in su per cercare un nostro cielo nei libri al restare piegati sopra a questi schermi per poi andare a comprare un libro che ci spieghi le storture degli schermi. I pellerossa avevano una vista acutissima perché esercitata a guardare sempre lontano. I cavalli da corsa hanno i paraocchi perché non si sa mai che gli venga di prendere la pista dalla parte opposta, o meglio ancora, mandare a ranare quel brutto mondo che gli gira intorno e saltare lo steccato.