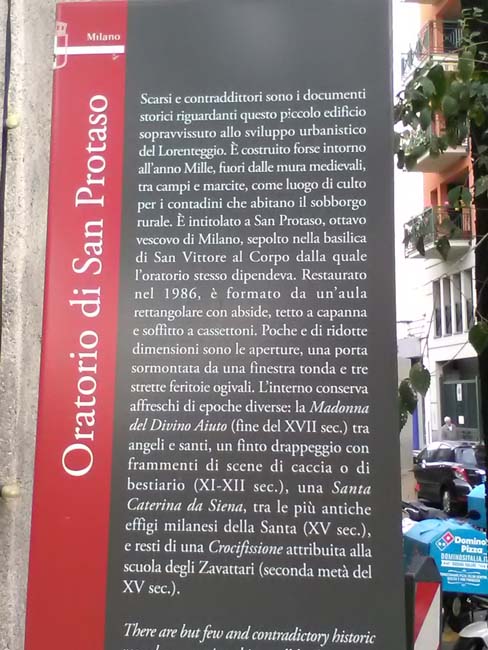Appena uscita dalla stazione, vedo una gran quantità di lumache giganti. Poiché è la prima volta che vado a Novara, mi chiedo divertita se è la città delle lumache.

 Si capisce che è un’installazione ma non trovo un cartello con una spiegazione esauriente, solo che è un’opera di riciclo. Scopro in seguito che di sera si illuminano, peccato non esserci perché devono essere proprio belle.
Si capisce che è un’installazione ma non trovo un cartello con una spiegazione esauriente, solo che è un’opera di riciclo. Scopro in seguito che di sera si illuminano, peccato non esserci perché devono essere proprio belle.
Queste mie gite fuori porta non sono mai improntate all’organizzazione; se mai dovessi sparire, non cercatemi in capo al mondo ma a 40 minuti da Milano. Ho già intuito qual è la strada che porta in centro ma almeno questa volta mi viene in aiuto un cartello. È dal cartello che scopro che la mia meta, il Castello, è Sforzesco-Visconteo.
Finito il viale più grande che dalla stazione porta a una grossa rotonda, prendo un corso pedonale che è già addobbato a festa. È grande e pieno di negozi, le vie ai lati sono invece piccole, spesso acciottolate, case basse che ricordano un po’ quelle di montagna. Entro in uno di questi vicoli attratta da un campanile.
È prodigioso come in qualunque posto il campanile sembri lì a due passi e invece man mano che ti avvicini sparisce, o si sposta, e inizi a girare in tondo per trovare quello che è attaccato sotto. Alla fine ci arrivo, alla basilica di San Gaudenzio, la cui cupola è stata progettata da Alessandro Antonelli, lo stesso della Mole Antonelliana di Torino.
All’interno della chiesa,
questa imponente statua del Salvatore che inalbera lo stendardo della vittoria, con una sua curiosa storia.
 Torno sui miei passi per non perdere la meta e mi ritrovo in quello che deve essere il centro del centro di Novara. Questi “cuori pulsanti” ormai li riconosco ancor prima di vedere il Duomo, arrivano dove i negozi caratteristici finiscono per lasciare spazio a quelli in franchising e dunque uguali in qualunque città, piccola o grande che sia.
Torno sui miei passi per non perdere la meta e mi ritrovo in quello che deve essere il centro del centro di Novara. Questi “cuori pulsanti” ormai li riconosco ancor prima di vedere il Duomo, arrivano dove i negozi caratteristici finiscono per lasciare spazio a quelli in franchising e dunque uguali in qualunque città, piccola o grande che sia.
La cattedrale, dedicata a Santa Maria Assunta, è un affascinante insieme di stili che spuntano solo dopo aver varcato un colonnato.

 Bello, nella sua semplicità, il battistero di fronte.
Bello, nella sua semplicità, il battistero di fronte.

 E così, eccomi in dirittura castello. Quando lo vedo, a chiudere una piazza di portici e di eleganti edifici, resto immobile qualche secondo. Purtroppo non stupefatta di bellezza. Il restauro è uno di quei casi in cui ti verrebbe voglia di prendere a sassate l’architetto usando gli stessi mattoni con cui lui ha eretto quell’orribile torre color edificio-Esselunga che tenta invano di amalgamarsi con le antiche mura.
E così, eccomi in dirittura castello. Quando lo vedo, a chiudere una piazza di portici e di eleganti edifici, resto immobile qualche secondo. Purtroppo non stupefatta di bellezza. Il restauro è uno di quei casi in cui ti verrebbe voglia di prendere a sassate l’architetto usando gli stessi mattoni con cui lui ha eretto quell’orribile torre color edificio-Esselunga che tenta invano di amalgamarsi con le antiche mura.
Abbasso la testa per non vedere lo scempio ed entro nel castello. In questi giorni così difficili e brutti la placida e nitida bellezza di certi artisti assume un valore che va oltre l’arte. È per la mostra Boldini, De Nittis et les italiens de Paris che sono qui.
Un’ora, due, non lo so quanto sono stata via, tra Parigi, Londra e altri posti, come al solito con questo stile quasi appiccicata a guardare dove il colore si accumula a creare un dettaglio e dove invece si alleggerisce in lunghe pennellate, dove i visi spesso netti si sciolgono in un resto sfumato, dove il netto e lo sfumato variano a seconda della distanza da cui ti poni. E poi l’eleganza dei vestiti, il divertimento, i luoghi di incontro, quelli che si ripropongono, come il Moulin de la Galette.
Francesco Paolo Michetti, Mattinata, 1878, particolare.
 Giuseppe De Nittis, La lezione di pattinaggio, 1875 ca.
Giuseppe De Nittis, La lezione di pattinaggio, 1875 ca.

Antonio Mancini, I giocattoli della bambina (il pittore dipingeva “alla prima”, cioè direttamente su tela senza disegno)

Federico Zandomeneghi, Le Moulin de la Galette, 1878 ca.
Vittorio Matteo Corcos, La farfalla, 1881.

Vittorio Matteo Corcos, Le istitutrici ai Campi Elisi, 1892, particolare.

Giovanni Boldini, Ritratto di Josefina Alvear, 1913 ca.

Giovanni Boldini, La contessa Speranza, 1899.

Vittorio Matteo Corcos, Ritratto di Lina Cavalieri, 1902 ca.
Nonostante le loro vite spesso tormentate, forse sono gli impressionisti gli ultimi artisti che hanno lasciato fuori dall’arte il dolore della storia, le angosce dell’animo.
Al di là dal castello c’è un parco e i colori dell’autunno avrebbero parlato à les italiens. Certamente parlano a me, se non fosse che la tramontana non si è ancora decisa a spostarsi più in là. Il sole non riesce ad attenuare il gelo di quelle folate che vanno e vengono e quindi, pur a malincuore, me ne vado io.
Un ultimo pezzo d’arte, con ombra, e infatti si intitola La grande ombra (di Costantino Peroni, 2003).